![]()
La Taranta: donne e dolore nella tradizione contadina del Sud
di Giuditta Simoncelli
Appartiene alla cultura del Sud
il concetto di liberazione rituale dal male, dalla possessione o
dall’ossessione, attraverso la danza. La valenza curativo-spirituale della
musica, accordata alla meccanica del corpo, acquista nel meridione, un
significato salvifico, di catarsi e purificazione, che fonda alcuni aspetti
originali del folclore locale, ma anche elementi del patrimonio culturale
italiano [e non solo] da difendere e trasmettere alle generazioni nuove.
La Taranta è una leggenda e un
fenomeno sociale, oltre che una cultura musicale.
Secondo la narrazione popolare,
durante la stagione dei raccolti, capitava spesso alle donne dei campi di
avvertire contrazioni dolorose, improvvise e lancinanti. Una sensazione di
soffocamento che era curabile solo e soltanto con l’intervento della musica e
l’induzione della colpita 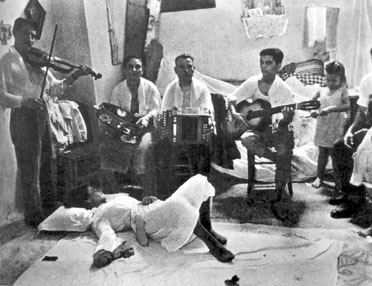 al ballo liberatorio. Ma questa possessione del morso durava anni, anche dopo una momentanea guarigione dai suoi effetti e ciclicamente
generava delle crisi annuali. Per questo, quelli che dal morso erano colpiti,
diventavano degli esposti alla pubblica coscienza della loro diversità. Con
l’avvicinarsi dell’anniversario della prima crisi, si preparavano al suo
rinnovarsi e al rito della “liberazione” che puntualmente avveniva.
al ballo liberatorio. Ma questa possessione del morso durava anni, anche dopo una momentanea guarigione dai suoi effetti e ciclicamente
generava delle crisi annuali. Per questo, quelli che dal morso erano colpiti,
diventavano degli esposti alla pubblica coscienza della loro diversità. Con
l’avvicinarsi dell’anniversario della prima crisi, si preparavano al suo
rinnovarsi e al rito della “liberazione” che puntualmente avveniva.
Così, attraverso movenze
convulse e sussultorie, in una forma di identificazione con il ragno
morsicatore, le donne colpite davano vita a una danza suggestiva e
impressionante, frenetica. La simbologia di questa tradizione sottende un’ampia
riflessione istintiva della cultura popolare che, nella spontaneità dei riti
campestri, esprime, attraverso queste figure al confine con la follia
inespressa, i “tarantolati”, la problematica di una condizione esistenziale dura,
difficile, al confine con la schiavitù sociale: quella della vita dei campi
nella storia. In modo particolare la frustrazione femminile, la condizione di
obbedienza nella cultura patriarcale, maschile dalla quale esse, emergono solo
attraverso la concessione di se stesse alla diversità del “malato” pur di
liberare il proprio io: una forma, dunque, in realtà, di ribellione, che i
ritmi incessanti della danza, sinuosa e scattosa, aggrovigliata, composta di
figure alternate, a tratti strisciante, a terra, altre inarcata in agili
movenze di elevazione, subito frustrate da nuove dolorose convulsioni, in un
crescendo che ripercorre la meccanica psicologica di un delirio senza fiato,
trasmettono a chi assiste coinvolgendolo sulla figura colpita in un’inquietudine
dilagante.
Dalla condizione particolare
della donna nella civiltà contadina, la taranta diviene l’espressione di una
condizione universale del dolore umano, della costrizione dello stato fisico o
sociale.
Negli ultimi anni anche
l’attenzione della cultura nazionale ha riscoperto le realtà locali, rileggendo
spesso opere del nostro patrimonio artistico attraverso le suggestioni
regionali. Così, non è difficile, soprattutto nelle rappresentazioni teatrali,
notare ispirazioni alla ritmica e all’espressione dialettale: la taranta è
indubbiamente una forma elevata di folclore che, tuttavia, non resta ancorata a
una visione particolare: permette una riflessione ben più ampia rispetto alla
cultura contadina da cui trae origine, a indagare la storia femminile, l’animo
della donna, la sua psicologia e la fragilità cui viene costretta dalle
consuetudini sociali. È, metaforicamente, la malattia, e la pubblica diversità
il prezzo da pagare per avere una voce dolorosa e lancinante nel mondo
maschile. La Taranta, oggi, è considerata un’arte assimilabile alla tradizione
spagnola del flamenco, anche se i circuiti di promozione culturale
folcloristica italiana sono ancora macchinosi e risentono di una staticità che
non hanno ancora superato. V’è indubbiamente una similitudine possibile tra la
danza Andalusa e quella salentina, nei profondi accordi di sensualità che
entrambe trasmettono: la corda dell’istinto, della passione e della rabbia, che
perdono il controllo razionale, imponendo l’individuo nella purificazione della
musica, sono un magico viaggio di colui che vi si affida, dal quale non facile
è il ritorno, senza sentire qualcosa di diverso, interiormente.
Avvicinandoci all’estate,
possiamo suggerire di fare diretta esperienza delle manifestazioni che in
numerosi paesi del Salento, in primis nella Grecìa, omaggiano questa
espressione della musica e della storia, e che vanno via via assumendo sempre
più interesse sul piano della cultura nazionale. Senza dubbio un’emozione da
non perdere e su cui riflettere.